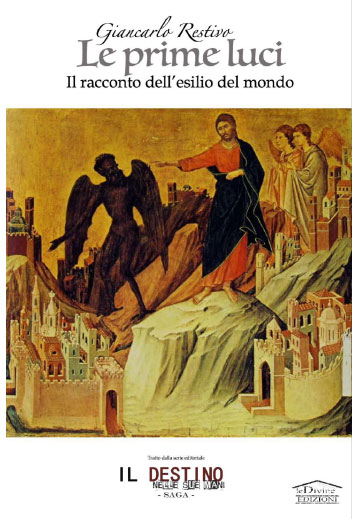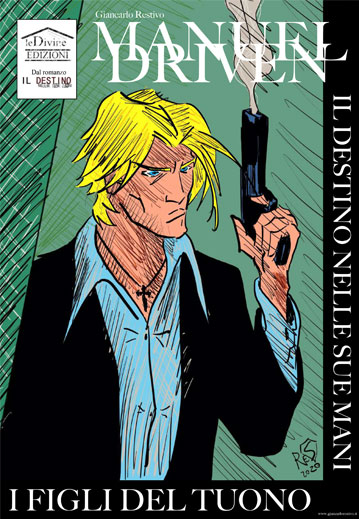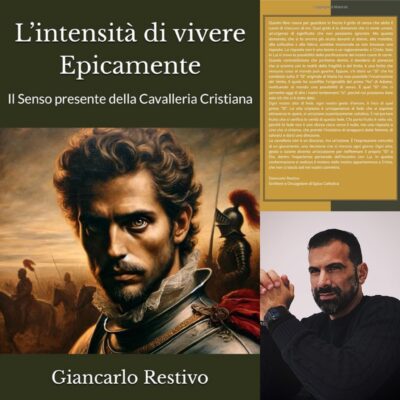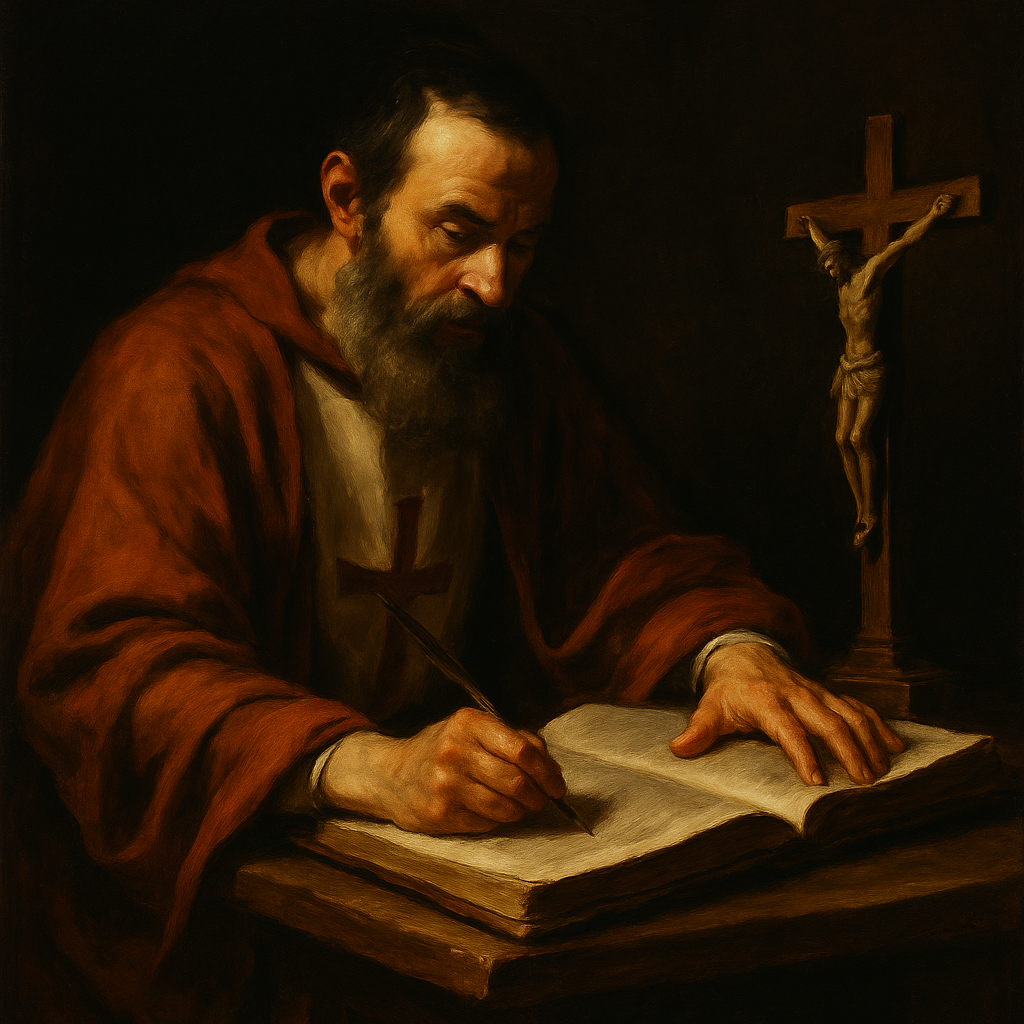1. Introduzione
L’Ordine del Tempio, nato nel XII secolo in seno alla Chiesa, era una realtà profondamente radicata nella fede cristiana, vincolata alla Regola approvata dal Concilio e vissuta sotto l’autorità diretta del Papa.
La sua missione univa vita monastica e difesa armata dei pellegrini e dei luoghi santi: un carisma originale, riconosciuto e guidato dalla grazia sacramentale, vissuto attraverso voti religiosi (povertà, castità e obbedienza) che configuravano il templare come monaco e cavaliere al tempo stesso.
2. La rottura del 1700
Nel XVIII secolo, a oltre quattro secoli dalla soppressione dell’Ordine, alcune correnti della massoneria speculativa vollero costruire un fondamento storico per sé, recuperando simboli e narrazioni templari.
Ma ciò che nacque non fu una continuazione autentica:
-
Non esisteva più alcun legame canonico o istituzionale con la Chiesa e con l’Ordine medievale.
-
Riti e prassi furono reinterpretati secondo schemi esoterici e gnostici, più vicini alla visione illuminista e umanista-autosufficiente che alla spiritualità cristiana.
-
La figura del templare venne romanticizzata, caricata di simbolismi estranei alla sua origine e depurata dell’obbedienza ecclesiale.
3. Il problema delle imitazioni in buona fede
Molte associazioni templariane contemporanee, pur animate dal desiderio sincero di riprendere la via cavalleresca, partono da questa rielaborazione settecentesca, e non dalla realtà storica medievale.
Questo comporta errori originali difficili da correggere:
-
Il voto diventa giuramento: nel Medioevo il templare faceva voto religioso, cioè riconosceva un’azione preveniente della grazia di Dio che lo sosteneva.
Il giuramento moderno, invece, pone l’accento sulla forza di volontà del soggetto, scivolando verso una concezione gnostica e volontaristica della salvezza. -
Il linguaggio cambia: si abbandona il linguaggio ecclesiale per un lessico iniziatico, ambiguo e autoreferenziale.
-
Il rito perde la sua radice sacramentale: slegato dai sacramenti, diventa solo simbolismo.
4. Il monito di San Bartolo Longo
San Bartolo Longo, che aveva conosciuto da vicino le seduzioni del sincretismo e dell’esoterismo, ammoniva con chiarezza che ogni mescolanza tra la fede cattolica e dottrine estranee conduce a un annacquamento della verità e a un inganno spirituale.
Per questo, chi desidera proporre oggi una cavalleria cristiana deve recidere ogni legame con ciò che dal 1700 ad oggi è nato in ambito iniziatico o massonico, anche se apparentemente “ripulito” o “battezzato”.
5. Una via autentica
Guardare al passato non per nostalgia, ma come suggerimento e ispirazione per il presente:
-
Riprendere i voti religiosi sotto forma di “promessa” come via di risposta alla grazia.
-
Vivere la cavalleria in comunione con la Chiesa e sottomessa al suo discernimento.
-
Recuperare una forma storica realistica, evitando sia la teatralità romantica sia le imitazioni ideologiche.
La cavalleria Templare cristiana contemporanea può esistere, ma non come riproduzione di un’epoca, bensì come testimonianza viva della verità nella carità, radicata nel Vangelo e fedele alla Tradizione.
Bibliografia
Fonti storiche medievali
-
Regola latina dei Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, approvata dal Concilio di Troyes (1129), ed. critica in La Règle du Temple, a cura di Henri de Curzon, Paris, Librairie Renouard, 1886.
-
Bernardo di Chiaravalle, De Laude Novae Militiae, in Opera Omnia, Cistercian Publications, Kalamazoo, 1977.
-
Acta Concilii Trecensis, 1129, in Recueil des Historiens des Gaules et de la France, vol. 14, Paris, 1806.
Studi storici sull’Ordine del Tempio medievale
-
Barber, Malcolm, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple, Cambridge University Press, 1994.
-
Nicholson, Helen J., The Knights Templar: A New History, Sutton Publishing, 2001.
-
Demurger, Alain, Vita e morte dell’Ordine del Tempio, Roma, Salerno Editrice, 2010.
-
Upton-Ward, J. M., The Rule of the Templars: The French Text of the Rule of the Order of the Knights Templar, Boydell Press, 1992.
Studi sulla rielaborazione settecentesca e massonica
-
Chailley, Jacques, Les Templiers sont parmi nous, ou l’Énigme de Gisors, Paris, Gallimard, 1962.
-
Kervella, André, Les Templiers et les Francs-Maçons: Histoire et légendes, Paris, Éditions Dervy, 2006.
-
Newman, Sharan, The Real History Behind the Templars, Berkley Publishing Group, 2007.
-
Le Forestier, René, La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Aubier-Montaigne, 1970.
Fonti magisteriali e testi ecclesiali
-
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sulla Massoneria, 26 novembre 1983.
-
Leone XIII, Humanum Genus, Enciclica contro la Massoneria, 20 aprile 1884.
-
Benedetto XVI, Spe Salvi, Lettera enciclica, 30 novembre 2007 (per il tema della speranza come dono e non sforzo umano autonomo).
San Bartolo Longo
-
Longo, Bartolo, Storia del Santuario di Pompei, Edizioni Santuario di Pompei, varie edizioni.
-
Santuario di Pompei, Scritti e lettere di Bartolo Longo, Napoli, 1990.
-
De Marco, Felice, Bartolo Longo: Dal baratro alla santità, Roma, Città Nuova, 2002.
Opere di riferimento sulla cavalleria cristiana contemporanea
-
Cardini, Franco, Alle radici della cavalleria medievale, Firenze, Giunti, 1981.
-
Restivo, Giancarlo, Fraternitas Caroli Magni – Appunti di formazione cavalleresca cristiana, Schola Carlo Magno, 2024.
-
Pontiggia, Giorgio, Cavalieri del Graal – Una proposta per i giovani, Milano, 1986 (dispense interne).
APPROFONDIMENTO:
Dame e cavalieri? Un errore di prospettiva (romantico-mondano)
La separazione formale “dame” / “cavalieri” che molte associazioni templariane moderne introducono come elemento identitario non proviene dall’Ordine del Tempio medievale né, più in generale, dalla prassi degli ordini religioso-militari del XII-XIII secolo. È invece il riflesso di una rielaborazione tardo-moderna (XVII-XVIII secolo) di marca cortigiana e nobiliare, poi romanticamente mitizzata nell’Ottocento.
1) Che cos’era la “dama” nel Medioevo
Nel lessico medievale la “dama” appartiene soprattutto alla letteratura cortese e al codice del fin’amor (il cavaliere serve la domina secondo un galateo simbolico). È una figura letteraria e sociale, non un titolo cavalleresco religioso-militare. Negli ordini come Tempio, Ospedalieri o Teutonici, la struttura è monastica e gerarchica: regola, voti, obbedienza, uffici. Non esiste un ceto femminile denominato “dame” come categoria cavalleresca equipollente ai milites. La Regola e gli Statuti insistono anzi sulla separazione degli spazi e sulla custodia dei costumi, escludendo la compresenza promiscua e l’ammissione femminile alla milizia armata.¹
2) La genealogia moderna della “dama d’ordine”
La figura della “dama” come membro di un ordine nasce e prospera in età moderna, nella cornice di corte e dei “ordini onorifici” nobiliari (non religiosi-militari): si pensi, per esempio, all’Ordine della Croce Stellata (Austria, 1668), all’Ordine di Santa Caterina (Russia, 1714), alla Real Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Spagna, 1792). Qui “dama” significa status e decoro di corte, non milizia evangelica né osservanza di regola monastica. Quando le associazioni templariste contemporanee introducono il binomio “dame/cavalieri”, stanno quindi importando un modello tardo-moderno, non recuperando la forma medievale.
3) Le donne nella tradizione cristiana: vocazione e missione, non “ruolo decorativo”
La storia ecclesiale conosce presenze femminili reali nella vita cavalleresco-assistenziale: sorores ospedaliere presso gli Ospedalieri e i Teutonici, comendadoras negli ordini iberici (Santiago, Calatrava) e rami femminili con voti e compiti amministrativi-assistenziali (non la milizia armata).² Esistono casi locali di onorificenze collettive conferite a donne per atti di difesa (il celebre, discusso caso delle donne di Tortosa nel XII secolo): segni di stima pubblica, non “ordini femminili di cavalleria” in senso stretto.
La grande eccezione provvidenziale è Santa Giovanna d’Arco: non “dama” di corte, ma guida militare per mandato riconosciuto, che agì sotto obbedienza e con voto di castità. Non fu “cavalierata” nel senso giuridico-feudale, ma la Chiesa la riconosce come segno che la missione nasce dalla grazia e non dal genere o dal censo.³
4) Conseguenza teologico-spirituale
Il modello “dame/cavalieri” scivola facilmente verso una simbologia cortigiana (status, decoro, giuramenti d’onore) distante dalla logica dei voti (povertà, castità, obbedienza) propri degli ordini medievali. Il voto riconosce un’azione preveniente della grazia e inserisce la persona in una forma ecclesiale; il giuramento d’onore tipico dei corpi nobiliari moderni accentua lo sforzo del soggetto e la volontà—con un rischio di volontarismo prossimo a sensibilità gnostiche. Per questo, anche quando animata da buona fede, la riproposizione della coppia “dama/cavaliere” non ricostruisce la forma storica cristiana, ma ne ripete un’imitazione modernista.
5) Criteri operativi per una cavalleria cristiana contemporanea
-
Nomenclatura: sostituire “dama/cavaliere” con sorelle/fratelli sotto la stessa Regola e lo stesso cammino di virtù.
-
Forma ecclesiale: centralità dei voti (o promesse ecclesiali) e della direzione spirituale, non di giuramenti cavallereschi d’onore.
-
Missione: priorità a carità, custodìa, testimonianza pubblica del Vangelo, discernite dall’autorità ecclesiastica.
-
Iconografia e simboli: evitare repertori romantici-salonieri; recuperare povertà formale e sobrietà proprie della tradizione monastica-militare.
-
Discernimento storico: lo studio della Regola del Tempio e degli Statuti (ed. critiche) come base, integrata dai migliori storici del monachesimo cavalleresco.
Note essenziali
-
Cfr. Regola e Statuti templari in ed. Upton-Ward; Barber; Nicholson.
-
Sui rami femminili e le comendadoras: studi su Santiago/Calatrava; per Ospedalieri e Teutonici, documentazione su sorores hospitalariae e case femminili.
-
Su Giovanna d’Arco: riconoscimento della missione e della santità; araldica concessa, ma non “cavalierato” feudale. L’esempio illumina la priorità della grazia sulla categoria sociale.
Riferimenti
-
M. Barber, The New Knighthood; H.J. Nicholson, The Knights Templar; A. Demurger, Vita e morte dell’Ordine del Tempio; J.M. Upton-Ward, The Rule of the Templars.
-
G. Duby, Il cavaliere, la donna e il prete; C.S. Lewis, The Allegory of Love; J. Huizinga, L’autunno del Medioevo (per la cornice cortese/romantica).
-
R. Le Forestier, La Franc-Maçonnerie templière…; S. Newman, The Real History Behind the Templars (per la ricezione moderna).
In sintesi: la distinzione “dame/cavalieri” è un innesto tardo-moderno su un tronco medievale che non lo prevedeva. Una cavalleria cristiana credibile oggi deve tornare ai voti e alla forma ecclesiale, dove la grazia — non il censo, non il genere, non il costume — stabilisce la missione.