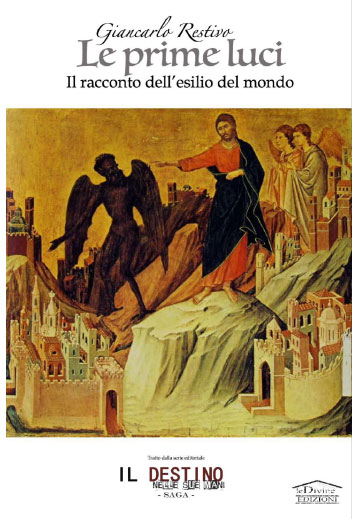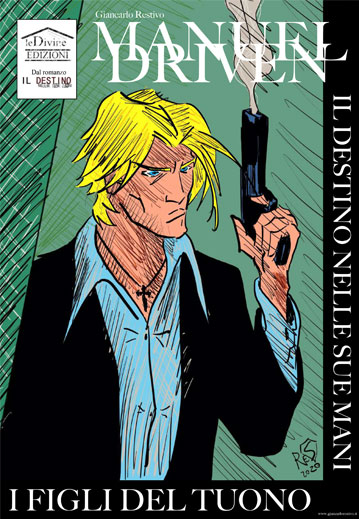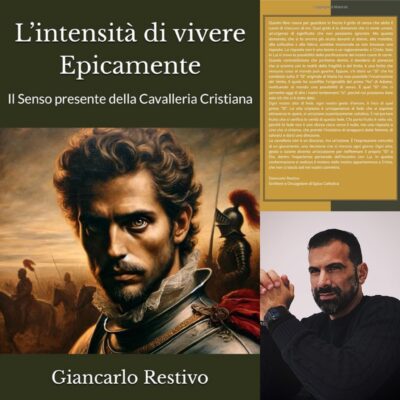1. Premessa: nessun “Filippo d’Orléans” fondò un Ordine Templare
Nella storia francese esistono diversi Filippo d’Orléans, tutti appartenenti a rami cadetti della famiglia reale, ma nessuno di essi ebbe un ruolo reale nella fondazione di un “Ordine del Tempio”.
L’equivoco nasce nel XIX secolo, quando alcuni autori occultisti e massonici, desiderosi di attribuire una legittimità “regale” alle proprie invenzioni rituali, usarono il nome di un Orléans per rivestire di nobiltà i loro circoli iniziatici.
In realtà, non esiste alcun documento autentico del XVII o XVIII secolo che provi una rifondazione templare patrocinata da un principe di sangue.
2. I tre Filippo d’Orléans e il mito esoterico
Il nome “Filippo d’Orléans” ricorre più volte nella storia francese e ciascuna figura, per motivi diversi, fu circondata da un’aura di eccentricità o di inclinazione al pensiero libero, che in epoca romantica divenne terreno fertile per l’invenzione di genealogie “templari”.
a) Filippo I d’Orléans (1640-1701)
Fratello minore di Luigi XIV, noto come Monsieur, fu un principe mondano e raffinato, più interessato alle arti che alla politica. Non fu massone ma alchimista sincretista e appassionato di scienze occulte — la massoneria moderna nasce solo nel 1717 — ma i suoi circoli parigini ospitavano spesso filosofi libertini e curiosi di scienze occulte ed esoteriche. In seguito gli ambienti illuministi lo trasfigurarono come “prototipo” del principe aperto al sapere esoterico, pur senza alcun fondamento rituale.
b) Filippo II d’Orléans (1674-1723)
Reggente di Francia durante la minore età di Luigi XV, è la figura più spesso citata dai templaristi moderni. Fu effettivamente vicino e legato a ambienti alchemici e rosacrociani, e il suo nome appare nei primi elenchi della proto-massoneria francese (intorno al 1715-1720).
Non fu però mai Gran Maestro templare, né lasciò traccia di un’adesione ad un “Ordine del Tempio”. La leggenda nasce nel tardo Settecento, quando alcuni massoni, volendo darsi una discendenza cavalleresca, sostennero che il Reggente fosse stato il restauratore segreto del Tempio.
Si tratta di una invenzione postuma, nata per nobilitare la massoneria con un’aura medioevale.
c) Filippo Egalité (1747-1793)
Discendente diretto dei precedenti, duca d’Orléans e futuro rivoluzionario, fu massone autentico, membro della Grande Loge de France e poi del Grand Orient de France.
Egalité sostenne la Rivoluzione e votò la condanna a morte di Luigi XVI; venne ghigliottinato nel 1793.
Nel suo caso, l’adesione massonica è storicamente certa, ma non ha nulla di templare: il suo pensiero era deista e razionalista, lontano da ogni mistica cavalleresca.
In sintesi, solo Filippo Egalité fu realmente massone, Filippo II ebbe curiosità esoteriche, mentre Filippo I fu un mecenate del libertinismo aristocratico pseudo-occultista.
Nessuno di loro ebbe rapporto con un Ordine templare, antico o moderno.
Il loro nome, però, fornì ai templaristi ottocenteschi un’aura dinastica utile a far credere in una continuità cavalleresca che non è mai esistita.
3. La vera nascita del “templarismo”: Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1804)
Il templarismo nasce in Francia nel 1804, quando Bernard-Raymond Fabré-Palaprat, medico e iniziato alla massoneria, fondò un presunto “Ordre du Temple”.
Fabré-Palaprat sosteneva di aver ricevuto da un misterioso “Jean-Marc Larmenius” una carta di trasmissione segreta, la cosiddetta Carta di Larmenius, secondo cui i Grandi Maestri templari si sarebbero succeduti in clandestinità dal 1312 fino a lui.
Questa carta si rivelò però un falso storico, scritto in un latino settecentesco e pieno di anacronismi.
Fabré-Palaprat creò rituali e statuti modellati sulla massoneria, mantenendo il simbolismo cavalleresco ma riempiendolo di contenuti sincretisti: un miscuglio di gnosi, rosacrocianesimo e illuminismo spiritualista.
Il suo “Ordine” non era cattolico, né riconosciuto da alcuna autorità ecclesiastica o civile: era una società iniziatica privata, parte del fenomeno più ampio del neo-templarismo romantico.
4. Dal mito templare al filone occultista
Dopo la morte di Fabré-Palaprat (1838), il movimento si frammentò in decine di ramificazioni:
-
alcune si riavvicinarono alla massoneria;
-
altre si orientarono verso un templarismo mistico-esoterico, collegato al martinismo e al rosacrocianesimo (Saint-Yves d’Alveydre, Éliphas Lévi, Papus);
-
altre ancora tentarono di darsi una parvenza cattolica, pur mantenendo rituali iniziatici incompatibili con la dottrina della Chiesa e ripudiati da essa.
In Italia, il filone arrivò nella seconda metà dell’Ottocento, attraverso circoli occultisti e massonici che usarono la simbologia templare come segno di ribellione contro la Chiesa e l’istituzione papale.
5. Il tentativo di “cattolicizzare” il templarismo
Nel Novecento vari personaggi, come Alessandro Vettori, tentarono di presentare il templarismo come compatibile col cattolicesimo, ma si trattò di un’operazione di facciata.
Dietro il linguaggio “cristiano” rimanevano riti, giuramenti e concezioni iniziatiche di derivazione massonica o occultista.
La Chiesa cattolica, infatti, non ha mai riconosciuto nessuna continuità né successione templare, come ribadito dal Pontificio Consiglio per i Laici nel 2012.
6. Conclusione: il templarismo come fenomeno culturale, non cavalleresco
Il cosiddetto “templarismo” non è la continuazione dei Cavalieri del Tempio, ma un prodotto culturale dell’Ottocento: una miscela di romanticismo, occultismo e nostalgia del Medioevo.
Il suo fascino deriva dall’immaginario cavalleresco, ma la sua natura è iniziatica/occultista, non ecclesiale.
I veri Templari — monaci e soldati di Cristo — non hanno lasciato eredi.
Tutte le “obbedienze templari” moderne derivano, direttamente o indirettamente, dal falso di Fabré-Palaprat, e quindi dal contesto massonico e occultista francese.
Fonti essenziali
-
Bernard-Raymond Fabré-Palaprat, Statuts Généraux de l’Ordre du Temple, Paris 1805
-
Alain Demurger, Les Templiers. Une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, Paris, Seuil, 2005
-
Pierre Mollier, Les Templiers et la Franc-Maçonnerie, Revue de la Franc-Maçonnerie, 2010
-
Marina Montesano, I nuovi Templari. Storia di un mito moderno, Il Mulino, 2017
-
Vatican – Pontificio Consiglio per i Laici, Nota sui movimenti che si richiamano ai Templari, 2012