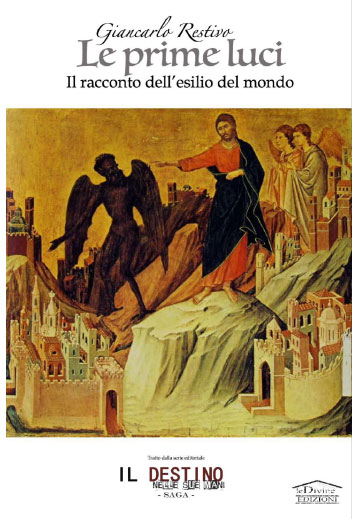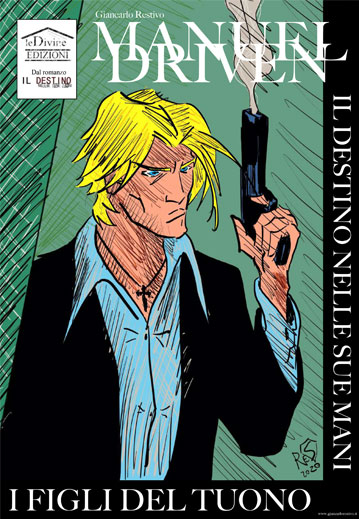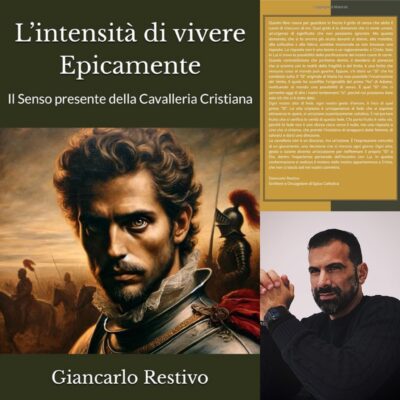1) Da dove riparte tutto: un Avvenimento
La conversione di Francesco non nasce da un ragionamento morale né da una pedagogia ascetica. Riparte da un avvenimento: qualcosa che prima non c’era e che irrompe nella sua esperienza — un incontro che lo tocca nel corpo e nel cuore, fino a cambiare il modo stesso di guardare sé e il mondo. Il cristianesimo entra così: non come idea, ma come Avvenimento che domanda risposta.
Qual è l’istante decisivo?
Francesco lo dice da sé, nel Testamentum (FF 110):
“Il Signore mi condusse tra i lebbrosi… e ciò che era amaro mi fu mutato in dolcezza di anima e di corpo.”
Qui l’amaro (ripugnanza, paura, impurità) diventa tenerezza: non perché Francesco si sforza, ma perché accade una Presenza che lo sorprende dentro il gesto più impensabile per un cavaliere: scendere da cavallo, toccare, baciare la carne ferita. Lì avviene la svolta: un Avvenimento che chiede adesione.
2) “Uno spacca il cuore, l’altro dà una direzione”
Chi dice “Lo ha convertito il Crocifisso di San Damiano” coglie solo metà del quadro. L’abbraccio al lebbroso è la ferita che apre la breccia; il Crocifisso è la Voce che entra in quella breccia.
- Il lebbroso: conversione nel corpo, nel disgusto vinto da una tenerezza nuova.
- Il Crocifisso: conversione nella missione — “Va’, ripara la mia casa” — e Francesco obbedisce come cavaliere, ma al Signore crocifisso.
3) La cavalleria capovolta
La cavalleria comunale sognava onore, armi, riconoscimento, giuramento di fedeltà al signore terreno. Francesco non smette di essere cavaliere: cambia Re. L’investitura non è più la spada, ma la spogliazione; il vassallaggio non è più alle mani di un conte, ma alla Chiesa che lo copre col mantello; la gloria non è più la vittoria, ma la fedeltà alla Presenza che lo ha afferrato. Questa è la “militia paupertatis”: povero perché libero, obbediente perché appartenente a un Altro.
4) La sequenza reale (non edulcorata)
Per evitare agiografie zuccherate, teniamo i passi nella loro nuda verità storica ed esistenziale.
- a) La prigione di Perugia (1202–1203)
Umiliazione, malattia, parassiti, bestemmie e disperazione attorno. Francesco consola i compagni — segno di un cuore fatto per il bene — ma non è ancora conversione. Qui crolla il mito dell’onore e nasce la domanda. (Nessun “maestro” lo converte: incontra la miseria dell’uomo e la propria finitezza.) - b) La crisi decisiva (1204–1205)
- Ultimo tentativo di cavalleria (desiderava divenire cavaliere): equipaggiamento nuovo, sogno di investitura.
- Incontro con un cavaliere povero: lo riveste con le proprie vesti — primo gesto veramente cavalleresco, ma rovesciato.
- La Voce nel sogno: “Chi può darti di più, il servo o il Padrone?” → Esiste un Altro Signore. Innesco non moralistico, ma ontologico.
- c) San Damiano (1205–1206)
Davanti al Crocifisso, una Voce presente: “Va’, ripara la mia casa.” Non un’emozione religiosa, un Ordine. Francesco obbedisce: vende, prende calce e pietre, fa. Lì la cavalleria viene rediretta alla Presenza che lo chiama. - d) La spogliazione (1206–1207)
Davanti al Vescovo: rinuncia alla casata e si riconsegna al Padre. È l’atto feudale rovesciato: appartenenza definitiva a Cristo nella Chiesa. (Il vescovo lo copre: la nuova signoria è ecclesiale.) - e) Il lebbroso (tra 1206 e 1207)
Qui Francesco indica l’inizio. Non un ideale, un incontro nel corpo. È il punto in cui la libertà aderisce a ciò che l’ha colpita; la ripugnanza cede a una affezione - f) I poveri, il Vangelo, i compagni (1207–1209)
La conversione diventa compagnia: la Parola ascoltata alla Messa, la fraternitas vissuta, i primi fratelli che aderiscono non a un’idea, ma a una Presenza incontrata, secondo una dinamica di appartenenza che genera popolo.
5) Sintesi teologica–esistenziale (la mappa in 8 mosse)
- La sconfitta — scopre che la gloria cavalleresca è vuota.
- La Voce — capisce che esiste un Altro Signore.
- Il Crocifisso — riceve una missione da Cristo vivo.
- Il lebbroso — si converte nel corpo, non in un’idea.
- Il Vescovo — rompe ogni appartenenza mondana.
- I poveri — riconosce la forma della fraternità.
- Il Vangelo — una Presenza nella Parola ridesta la vita.
- I compagni — la conversione diventa fattore storico.
6) Perché tutto questo (avvenimento, adesione, appartenenza) è decisivo
Parlare di Avvenimento protegge la fede dall’astrattezza: è qualcosa che accade, tocca, si vede; perciò esige adesione (la libertà che dice “sì”) e genera appartenenza (un “noi” reale che cambia il modo di giudicare e di operare). È così che la conversione di uno diventa popolo e cultura nuova.
In questo orizzonte, la cavalleria non è cancellata, ma portata a verità:
- Onore → non più dagli uomini, ma da Dio.
- Forza → non dominio, ma carità operosa.
- Fedeltà → non al feudo, ma alla Presenza che mi ha amato per prima.
7) In chiusura
Francesco non cambia carattere, cambia appartenenza. La sua è la storia di un uomo afferrato da un Avvenimento e condotto in una compagnia dove l’onore non si conquista, si riceve. Per questo può dirsi cavaliere dell’Altissimo:
la spada è la Parola, lo scudo la povertà, lo stendardo il Tau.
E la vittoria? Obbedire alla Presenza che — dal lebbrosario a San Damiano — gli ha chiesto il cuore e gli ha dato un popolo.
Bibliografia essenziale
1. Fonti Francescane
-
Fonti Francescane. Nuova Edizione, a cura di E. Menestò e S. Brufani, Edizioni Porziuncola, Assisi, 2023.
(Raccolta completa delle fonti primarie: Testamentum, Vita Prima e Vita Seconda di Tommaso da Celano, Legenda Maior e Legenda Minor di Bonaventura, Compilatio Assisiensis, Speculum Perfectionis, Fioretti.)
🔹 Riferimenti principali:-
Testamentum, FF 110
-
Vita Prima, FF 338, 356–365
-
Legenda Maior, FF 1042–1043
-
Compilatio Assisiensis, FF 1455
-
-
San Francesco d’Assisi, Scritti, a cura di C. Paolazzi, Edizioni Porziuncola, Assisi, 2019.
(Edizione critica dei testi autografi o attribuiti con certezza a Francesco: Regole, Lettere, Ammonizioni, Testamentum.) -
Bonaventura da Bagnoregio, Legenda Maior sancti Francisci, in Opera Omnia, Quaracchi, 1882, vol. VIII.
-
Tommaso da Celano, Vita Prima S. Francisci e Memoriale nel desiderio dell’anima (Vita Seconda), in Fonti Francescane, cit.
2. Studi francescani classici
-
Chiara Frugoni, Vita di un uomo: Francesco d’Assisi, Einaudi, Torino, 1995.
(Analisi storico-filologica: la crisi cavalleresca e la genesi dell’esperienza evangelica.) -
Raoul Manselli, San Francesco d’Assisi, Roma-Bari, Laterza, 1980.
(Ricostruzione storica rigorosa della formazione e della conversione del santo.) -
André Vauchez, François d’Assise. Entre histoire et mémoire, Fayard, Paris, 2009.
(Lettura critica del mito francescano e del suo sviluppo ecclesiale.) -
Julien Green, Francesco d’Assisi, Morcelliana, Brescia, 1982.
(Interpretazione spirituale e letteraria, utile per il linguaggio esperienziale.) -
Eloi Leclerc, La saggezza di un povero, Edizioni Messaggero, Padova, 1992.
(Opera mistico-poetica che esprime la “cavalleria dello spirito” francescana.)
3. Studi teologici e spirituali
-
Carlo Paolazzi, Francesco d’Assisi e il Vangelo vissuto, Edizioni Porziuncola, Assisi, 2008.
(Lettura teologico-biblica delle fonti, con enfasi sulla conversione come evento cristologico.) -
E. Caroli, La povertà come forma di libertà in San Francesco, Ed. Antonianum, Roma, 2011.
(Analisi della militia paupertatis come nuovo modello cavalleresco.) -
Giovanni Miccoli, Storia religiosa dell’Occidente medievale, Laterza, Roma-Bari, 2004.
(Contestualizza la frattura tra cavalleria feudale e riforma evangelica.) -
Chiara Mercuri, San Francesco e il Sultano. La storia e il mito, Laterza, Roma-Bari, 2019.
(Studio sul rovesciamento dell’immaginario militare in dialogo e pace.)
4. Studi sul linguaggio ecclesiale e antropologico (riferimento metodologico)
-
Luigi Giussani, Il senso religioso, Rizzoli, Milano, 1997.
-
Luigi Giussani, Perché la Chiesa, Rizzoli, Milano, 2003.
(Categorie fondative: Avvenimento, Adesione, Appartenenza, Affezione, Obbedienza.) -
J. Ratzinger (Benedetto XVI), Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia, 2005.
(La fede come incontro personale con Cristo, non come dottrina astratta.) -
Romano Guardini, San Francesco d’Assisi, Morcelliana, Brescia, 1996.
(Lettura teologico-antropologica del rovesciamento della cavalleria.)
5. Studi e documenti sul simbolismo cavalleresco
-
Georges Duby, L’Europa nel Medioevo. Nobiltà e cavalleria, Laterza, Bari, 1980.
-
Jacques Le Goff, L’uomo medievale, Laterza, Bari, 1987.
-
Francesco Bruni, Cavalleria e santità: l’eroismo cristiano da Bernardo a Francesco, Studium, Roma, 2001.
-
Egidio Canone, La milizia spirituale in San Francesco, Antonianum, Roma, 2014.
6. Riferimenti liturgico-magisteriali
-
San Giovanni Paolo II, Lettera ai Francescani nel VIII centenario della nascita di San Francesco, 1982.
-
Papa Benedetto XVI, Catechesi su San Francesco d’Assisi, Udienza generale, 27 gennaio 2010.
-
Papa Francesco, Lumen Fidei (2013) e Fratelli Tutti (2020): sviluppo contemporaneo del paradigma di fraternità come cavalleria evangelica.
7. Edizioni consigliate per uso didattico e lezioni
-
Fonti Francescane. Edizione economica annotata, Ed. Porziuncola, 2020.
-
E. Leclerc, La saggezza di un povero, per lettura narrativa.
-
C. Paolazzi (a cura di), Francesco e la cavalleria dello spirito, Ed. Antonianum, 2018.