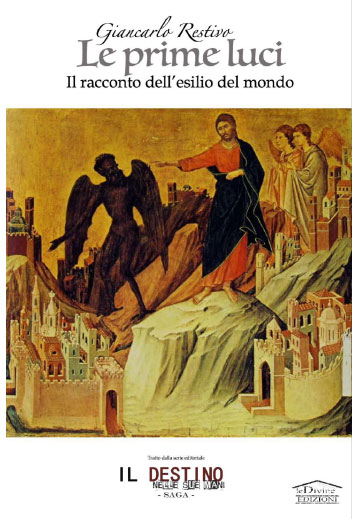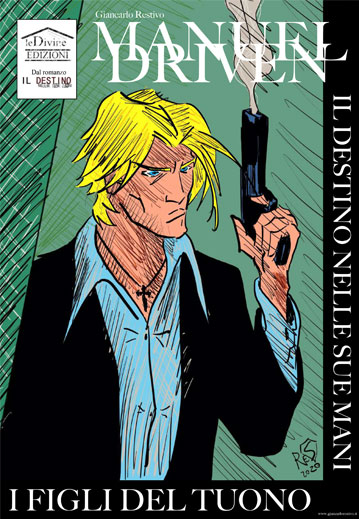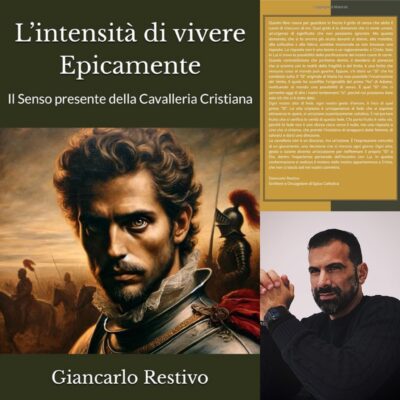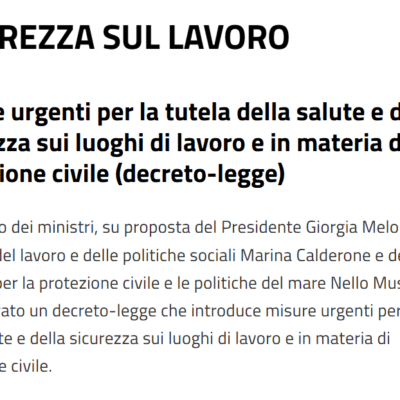Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è entrata anche nel mondo della salute e sicurezza sul lavoro: algoritmi che leggono DVR e report, sistemi che classificano gli infortuni, software che compilano registri e scadenziari quasi in automatico.
La conseguenza è chiara: il tempo dedicato alla produzione documentale diminuirà. E questo non è (solo) un vantaggio operativo: è un cambio di paradigma.
Se la carta la fa la macchina, la professionalità del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e dei consulenti non potrà più essere misurata a peso di faldoni, ma sulla qualità delle relazioni e sulla trasformazione reale dei comportamenti in azienda.
1. L’IA asciuga la carta, ma non sostituisce il mestiere
Studi e report internazionali convergono su un punto: l’IA in ambito H&S è soprattutto uno strumento di automazione dei compiti ripetitivi (raccolta dati, data entry, classificazione, monitoraggi) e di analisi avanzata dei dati di rischio.
-
L’EU-OSHA sottolinea che l’IA può monitorare ambienti e processi, prevedere rischi e automatizzare parte delle attività di controllo, ma richiede professionisti in grado di interpretare i risultati e governarne l’uso.
-
La letteratura rivolta ai professionisti H&S evidenzia che l’IA riduce l’onere amministrativo e documentale, spostando il ruolo del safety professional verso attività strategiche, gestione dei dati e lavoro sul comportamento umano.
In altre parole: l’IA fa più in fretta i compiti “di ufficio”; resta all’uomo tutto ciò che richiede giudizio, relazione, responsabilità.
Non a caso molte riflessioni sulla cultura della sicurezza insistono su un concetto ormai ricorrente: “Safety is not paperwork”, la sicurezza non è la carta, ma la capacità di evitare che le persone si facciano male.
2. Dal “tecnico della norma” al regista delle relazioni
Se la parte documentale verrà sempre più automatizzata, il valore aggiunto del SPP sta altrove:
-
nelle relazioni verticali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, HR);
-
nelle relazioni orizzontali (lavoratori, RLS, consulenti, manutentori, appaltatori);
-
nella capacità di trasformare dati in decisioni condivise e comportamenti osservabili.
La letteratura scientifica sulla sicurezza lo conferma da anni:
-
Le meta-analisi mostrano che la leadership in materia di sicurezza e la qualità delle relazioni capo–collaboratore sono fattori chiave per ridurre infortuni e migliorare i comportamenti sicuri.
-
Supervisori che comunicano, ascoltano e supportano la sicurezza generano più partecipazione attiva, segnalazione di quasi incidenti e rispetto delle procedure anche in assenza di controllo diretto.
Questo significa che l’RSPP e il consulente non possono più limitarsi a “consegnare un DVR fatto bene”, ma devono diventare:
-
facilitatori di dialogo tra management e lavoratori;
-
coach della linea per preposti e capi reparto;
-
animatori di cultura più che compilatori di schede.
3. Formazione e addestramento: contano i risultati, non il registro firme
Uno dei campi dove l’IA alleggerirà molto il lavoro è la gestione della formazione: piani formativi automatici, tracciamento scadenze, registri digitali, questionari corretti in tempo reale.
Ma la ricerca internazionale è chiara: non basta fare formazione, conta il trasferimento della conoscenza sul lavoro.
-
Una recente meta-analisi sulla formazione alla sicurezza evidenzia effetti medi da moderati a grandi su reazioni, apprendimento e trasferimento (cioè l’uso effettivo di ciò che si è appreso), mentre l’impatto diretto su infortuni e indicatori di sicurezza è più modesto se non viene sostenuto nel tempo.
-
Studi sul training transfer sottolineano che la formazione è efficace quando inserita in un sistema che prevede: coinvolgimento dei capi, follow-up sul campo, feedback continui, e quando il clima di sicurezza supporta l’uso dei comportamenti appresi.
-
Ricerche dell’IOSH mostrano come programmi integrati di formazione e leadership abbiano ridotto gli incidenti di oltre il 20% e migliorato in modo significativo il clima di sicurezza.
Tradotto per il SPP e i consulenti:
La vera professionalità non è solo più “fare il corso”, ma verificare se il corso cambia davvero ciò che accade in ambiente.
Qui l’IA può aiutare (es. analytics sulle segnalazioni, correlazioni tra formazione e near-miss), ma il lavoro fondamentale resta umano:
-
colloqui con preposti e lavoratori dopo i corsi;
-
osservazioni sistematiche sul campo durante l’addestramento;
-
aggiustamenti continui delle procedure sulla base di ciò che si vede in pratica.
4. Il fattore umano: non solo nei lavoratori, ma anche nei professionisti della sicurezza
Quando si parla di “fattore umano” pensiamo quasi sempre alle risorse lavorative: errori, distrazioni, stress, carichi di lavoro, competenze.
Con l’arrivo dell’IA, però, diventa evidente un altro livello: il fattore umano dei professionisti della sicurezza stessi.
L’IA può:
-
leggere più dati di quanti ne abbia mai visti un RSPP in tutta la sua carriera;
-
suggerire priorità di intervento, cluster di rischio, pattern di infortunio;
ma non può sostituire:
-
la credibilità costruita nel tempo con la linea;
-
la capacità di entrare in un reparto e farsi dire “la verità” dai lavoratori;
-
l’intuizione che nasce dal vedere come si lavora davvero, non solo come è scritto in procedura.
Il professionista della sicurezza del “dopodomani” dovrà quindi potenziare competenze come:
-
ascolto attivo e gestione dei conflitti (es. tra produttività e sicurezza);
-
mediazione tra esigenze operative e vincoli normativi;
-
capacità di storytelling per tradurre dati e algoritmi in messaggi comprensibili a operatori, capi e top management;
-
leadership di prossimità, cioè esserci fisicamente dove il lavoro avviene.
5. “La sicurezza non si è mai fatta da dietro una scrivania”
Da anni molti esperti ripetono che la sicurezza non coincide con la conformità formale. Alcuni sintetizzano così:
“Compliance is not safety, it’s the minimum.” AMG Ltd
La tecnologia sta togliendo ogni alibi: se la macchina compila DVR, registra formazione, monitora le temperature, segnala anomalie, allora diventa ancora più evidente che:
-
la sicurezza vera si gioca nelle relazioni, nei comportamenti, nelle micro-decisioni di ogni turno;
-
il ruolo del SPP è stare sul campo, leggere contesti, ascoltare, negoziare, accompagnare il cambiamento.
Gli studi sul legame tra safety leadership, clima di sicurezza e risultati operativi mostrano che quando i capi parlano di sicurezza in modo credibile, coerente e continuo, gli infortuni calano e aumenta la segnalazione spontanea di criticità.
In questo scenario, il SPP e i consulenti diventano:
-
partner della linea nel costruire questa leadership;
-
traduttori tra linguaggio tecnico e operatività quotidiana;
-
garanti del senso: ricordano che la sicurezza non è un obbligo burocratico, ma un modo concreto di prendersi cura delle persone.
6. L’IA fa i documenti, noi facciamo sicurezza
In sintesi:
-
L’IA ridurrà il tempo dedicato alla produzione documentale e renderà sempre più automatizzabili molte attività di analisi e reporting.
-
La professionalità del SPP e dei consulenti dovrà quindi spostarsi con decisione verso:
-
relazioni verticali e orizzontali;
-
verifica dell’efficacia reale della formazione;
-
osservazione e sviluppo di comportamenti sicuri in addestramento e sul lavoro.
-
-
Il fattore umano rimane centrale:
-
nei lavoratori (errori, limiti, potenzialità);
-
nei professionisti della sicurezza, chiamati sempre più a essere leader di cultura, facilitatori e coach.
-
-
La sicurezza sul lavoro non si è mai fatta – e oggi ancora meno – da dietro una scrivania: si fa nei reparti, nei magazzini, sui mezzi, nei cantieri, negli uffici dove si prendono decisioni, con la presenza concreta di chi la sicurezza la guida e la testimonia.
L’IA ci toglierà di mano la penna del verbale, ma ci mette in mano qualcosa di più impegnativo: la responsabilità di usare il tempo liberato per stare davvero con le persone.
E lì, sul campo, la differenza la farà sempre l’uomo.